|
| |
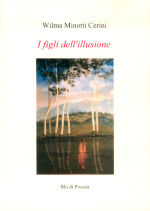 I Figli dell’illusione è un’espressione che definisce coloro che
perseguono il potere per il potere, creando schiavi legati, con catena,
all’interesse di chi persegue il potere per il potere. Da ciò, l’aforisma
dell’Autrice: il potere per il potere genera schiavitù.
Questo è un concetto radicato nella cultura dell’India ben nota
all’Autrice (ricordo ad esempio la sua raccolta di poesie Alla ricerca di
Shanti, del 1993 e del 2001), la quale nel libro ne espone la globale
visione del mondo, soprattutto morale ed esistenziale, attraverso l’incontro di
un cittadino americano, Peter Grows, con un Santo, un monaco che vive totalmente
l’esperienza mistica buddista. La conoscenza di sé, nel senso della discesa
nel più profondo della propria anima dove l’uomo trova Dio, è il bene più
grande, e da quella conoscenza deriva ogni altra possibilità di bene, anche sul
piano delle attività che concernono la vita di relazione e la società umana,
compresa la necessità di reprimere il male nel mondo e di realizzare il bene
collettivo. I Figli dell’illusione è un’espressione che definisce coloro che
perseguono il potere per il potere, creando schiavi legati, con catena,
all’interesse di chi persegue il potere per il potere. Da ciò, l’aforisma
dell’Autrice: il potere per il potere genera schiavitù.
Questo è un concetto radicato nella cultura dell’India ben nota
all’Autrice (ricordo ad esempio la sua raccolta di poesie Alla ricerca di
Shanti, del 1993 e del 2001), la quale nel libro ne espone la globale
visione del mondo, soprattutto morale ed esistenziale, attraverso l’incontro di
un cittadino americano, Peter Grows, con un Santo, un monaco che vive totalmente
l’esperienza mistica buddista. La conoscenza di sé, nel senso della discesa
nel più profondo della propria anima dove l’uomo trova Dio, è il bene più
grande, e da quella conoscenza deriva ogni altra possibilità di bene, anche sul
piano delle attività che concernono la vita di relazione e la società umana,
compresa la necessità di reprimere il male nel mondo e di realizzare il bene
collettivo.
Del resto, l’identificazione dei figli dell’illusione non
si appunta solo sui “grandi” del potere, sugli individui che conducono le
strategie di potere nel mondo: ognuno ha un “potente” dentro di sé che vuole
assoggettare gli altri al proprio comodo. «Sì, in un certo senso tutti siamo
figli dell’illusione, fino a che non ricerchiamo la fonte primigenia della vita,
la dignità perduta che ci rende ciechi». Il meccanismo che ci fa “ciechi”, che
ci fa cercare il “potere” è, a sua volta, la paura: la paura di passare
inosservati, la paura di valere meno degli altri, di non apparire abbastanza…
Contro la paura e quindi contro la smania di potere c’è solo un rimedio:
l’amore.
L’amore, ad un certo momento, si rende narrativamente evidente
quando, in una specie di immersione interiore nell’unità cosmica, il
protagonista del racconto percepisce la presenza di un amico d’infanzia, appena
morto – ma di cui egli non sapeva che fosse morto e neppure che anni addietro si
era fatto monaco –, il quale, al fine di realizzare il percorso che lo porterà
alla piena realizzazione della sua anima, ha bisogno di tornare in vita per tre
anni, e a tale scopo chiede a Peter di poter essere suo figlio, di poter essere
generato da lui, per poi morire, appunto, a tre anni di età. Si tratta,
indubbiamente, di una prospettiva pesante, dolorosissima per Peter – generare un
figlio che sarebbe di sicuro morto dopo tre anni –, ma che Peter (previo
eventuale consenso della sua donna) accetta, mosso dalla “luce” di bene da cui
si sente invaso nell’anima e nel corpo.
L’esposizione del pensiero buddista trova qui un forte spunto narrativo, che si
conclude con la scoperta, da parte del protagonista, che tutto è stato un sogno:
egli ha sognato il colloquio col Santo, ha sognato la presenza, invisibile,
dell’amico d’infanzia che gli ha chiesto di poter diventare suo figlio… Ma ciò
che è reale – o, se vogliamo, che è il sogno nel senso spirituale del termine –
è il sentimento profondo in cui si racchiude l’intera concezione esposta nel
libro e con cui si conclude il libro, verso la fine: «Chi potrebbe muoversi,
lottare e vivere in questo mondo, se il cielo non fosse pieno d’amore?». A
livello narrativo, la realtà di questo discorso sull’amore – l’amore che riempie
l’universo e che salva l’uomo dalla tentazione e dalla inclinazione del
“potere”, che è di per sé sopraffazione dell’uomo sull’uomo, cioè
schiavizzazione di un essere da parte di un altro essere – è costituito
dall’invenzione che, svegliatosi dal sonno, il propagonista che ha sognato tutto
legge sul giornale che in realtà quel suo amico, John Parker, era davvero morto,
appunto da poco, facendo scudo con il suo corpo ad un giovane sconosciuto, in
una sparatoria…
| |
 |
Recensione |
|