|
| |
Passive perlustrazioni
Un’umanità fallimentare si annida nelle strade di Roma, come sopravvissuta a
un’epoca che senza essere bellica è riuscita a moltiplicare ugualmente i suoi
morti. È stravolta dagli eccessi, dalle psicosi, dalle frustrazioni, dai veleni
intimi e dagli scarichi gassosi delle migliaia di macchine che attraversano
incessantemente la capitale dell’ex impero romano e monarco-fascista.
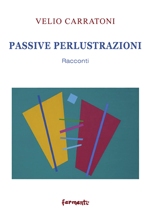 Le antenne
ben rizzate di Velio Carratoni, da quasi cinquant’anni motore delle edizioni
Fermenti e dell’omonima rivista, hanno intercettato questa fenomenologia
inquietante, incroci 39 Recensioni 141 elaborandola in una scrittura omeopatica
che usa un bisturi indurito nel gelo dell’autopsia. S’intitola Passive
perlustrazioni l’ultima raccolta di racconti dell’autore romano, e già le due
parole di un pezzo eponimo dicono quanta poca vita rimanga nel fondo di identità
che hanno abdicato a una qualunque evoluzione. Le antenne
ben rizzate di Velio Carratoni, da quasi cinquant’anni motore delle edizioni
Fermenti e dell’omonima rivista, hanno intercettato questa fenomenologia
inquietante, incroci 39 Recensioni 141 elaborandola in una scrittura omeopatica
che usa un bisturi indurito nel gelo dell’autopsia. S’intitola Passive
perlustrazioni l’ultima raccolta di racconti dell’autore romano, e già le due
parole di un pezzo eponimo dicono quanta poca vita rimanga nel fondo di identità
che hanno abdicato a una qualunque evoluzione.
La penna di Carratoni insiste
sull’anatomia e sulla fisiologia delle sue creature, presentando pezzi a sé
stanti di corpi ridotti a un funzionamento meccanico, che segnalano la loro
vitalità solo attraverso madori e sudori, ossia attraverso la rivelazione di uno
scioglimento o liquefazione paurosamente prossima. È un realismo feroce che non
può non trasformarsi in graffiante espressionismo e che risale a una tradizione
che si può riconoscere almeno nel primo Alberto Moravia, con striature
sarcastiche e amare che rimandano a Ercole Patti e a Ennio Flaiano. Una
scrittura da moralista che, d’altronde, non può fare a meno di guardare al
cinema di Federico Fellini e a certe pose di quello di Paolo Sorrentino,
specialmente quando il tema tocca il disfacimento di una città e l’ebbrezza
tragica di un suo imminente funerale. A un certo punto un personaggio afferma
nel racconto Gelo: «Ormai il contorno è saturo. Le parole incomprensibili. Ci
rimangono gesti da automi da fantascienza. Ogni detto diviene esibizione da
sogni infranti. Mi succede da tempo che le parole di Nanni, Federico o Giacomo
le senta come fossero guaiti nel deserto».
È la spia di un significato più
complessivo, che riassume efficacemente il livello di analisi spietata a cui Carratoni ha condotto la vivisezione di personaggi che non sono impegnati
propriamente nel plot di una storia, ma pronunciano la loro fantasmatica
presenza in una specie di surplace atemporale, vicino a certe suggestioni
figurative di un De Chirico o di un Hopper. Più che costruire una linea
narrativa, Carratoni cerca di cogliere ciò che resta della sostanza vaporizzata
di persone che sembrano non poter più comunicare, comprendersi, ascoltare,
riconoscersi, come se fossero risucchiate da una forza misteriosa, dissolutoria,
corrosiva. Parleremo di allarme antropologico denunciato così plasticamente da
Carratoni? Queste vite da robot, telecomandate, teledirette, telesvuotate ci
sembrano davvero affacciate al loro abisso.
C’è qui tutta la consapevolezza di
un tale stato di cose, del prezzo pagato a una modernizzazione che è stata più
veloce e distruttiva di ogni memoria, di ogni sincero umanesimo, di un avveduto
equilibrio tra Spirito e materia (come recita il titolo dell’ultimo racconto
della raccolta), in cui l’armonia o la sintonia tra spartito musicale della
violinista Lena e la sua quotidiana esistenza sta diventando, come tutti i
contatti e i riferimenti, «un cielo di fredde realtà squallide e false». La
forza dello scrittore sta nell’estrema coerenza progettuale e stilistica (uno
stile sussultorio, sincopato, denudante) con cui ha affrontato tale scenario
apocalittico, astenendosi da dozzinali ricette giudiziarie. E non si pensi,
d’altra parte, che il disastro riguardi solo Roma e i suoi abitanti, scelti
dalle classi medioborghesi, giacché qui la capitale fa da campione
rappresentativo di un fenomeno che sappiamo ormai globale.
Se l’egosfera è in
subbuglio, la globosfera non ne può che soffrire senza però arrendersi al male
come unica chance. Dovremo riconoscere che occorre resistere al male (anche se
qui Walter Siti sarebbe in disaccordo), superarlo con le pur ricche risorse di
cui l’uomo è dotato almeno fin dai tempi di Socrate.
| |
 |
Recensione |
|