|
| |
Luce crepuscolare
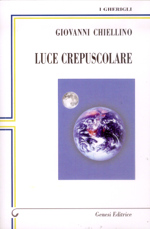 Sebbene sia
meno strutturata rispetto ad alcuni dei libri precedenti, dove prevaleva una
tendenza poematica per di più sostenuta da tematiche forti, quest'ultima silloge
di Giovanni Chiellino, Luce crepuscolare, non è semplicemente una
raccolta di liriche sparse, ma mostra anzi un nucleo ispirativo unitario e offre
anche qualche segreto legame sotterraneo a ribadire una genesi sostanzialmente
omogenea. Due le sezioni e piuttosto ampie, eponima la prima, mentre la seconda,
Pusilla, nonostante il titolo riduttivo che allude a 'piccolezze' o 'cose
da nulla', non si allontana dai motivi svolti nella precedente, che al contrario
sviluppa e approfondisce: prima di tutto l'intensa figura femminile che sembra
emergere dal passato e vivere nel ricordo soffusa di luminosa bellezza, ma
ancora occupa il presente e accende i sensi, e poi la stessa poesia che si
incarica di cantare questa bellezza, di celebrare le opere e i giorni altrimenti
destinati a perdersi per sempre, gli affetti familiari e i luoghi che si sono
incisi nell'anima, opponendosi all'inesorabile trascorrere del tempo. Ne deriva
una continua tensione verso l'eterno, tema molto caro a Chiellino, un vero e
proprio ardore di eternità, nel quale ogni singolo momento, per quanto
memorabile, è trasceso in un'ansia di fermezza, di un punto d'arrivo finalmente
pacificato. Sebbene sia
meno strutturata rispetto ad alcuni dei libri precedenti, dove prevaleva una
tendenza poematica per di più sostenuta da tematiche forti, quest'ultima silloge
di Giovanni Chiellino, Luce crepuscolare, non è semplicemente una
raccolta di liriche sparse, ma mostra anzi un nucleo ispirativo unitario e offre
anche qualche segreto legame sotterraneo a ribadire una genesi sostanzialmente
omogenea. Due le sezioni e piuttosto ampie, eponima la prima, mentre la seconda,
Pusilla, nonostante il titolo riduttivo che allude a 'piccolezze' o 'cose
da nulla', non si allontana dai motivi svolti nella precedente, che al contrario
sviluppa e approfondisce: prima di tutto l'intensa figura femminile che sembra
emergere dal passato e vivere nel ricordo soffusa di luminosa bellezza, ma
ancora occupa il presente e accende i sensi, e poi la stessa poesia che si
incarica di cantare questa bellezza, di celebrare le opere e i giorni altrimenti
destinati a perdersi per sempre, gli affetti familiari e i luoghi che si sono
incisi nell'anima, opponendosi all'inesorabile trascorrere del tempo. Ne deriva
una continua tensione verso l'eterno, tema molto caro a Chiellino, un vero e
proprio ardore di eternità, nel quale ogni singolo momento, per quanto
memorabile, è trasceso in un'ansia di fermezza, di un punto d'arrivo finalmente
pacificato.
Particolare
attenzione merita il componimento che intitola la prima sezione e dunque
l'intero libro, a cominciare dalla disposizione strofica: un verso isolato, di
solito un endecasillabo che si chiude con il punto interrogativo, si alterna a
un gruppo di tre versi, che anche se non costituisce una risposta diretta alla
domanda precedente, dà vita a un efficacissimo ritmo altalenante, ora incalzante
ora riposato. Da notare inoltre che tutti i versi hanno eccezionalmente
l'iniziale maiuscola, come si usava nell'Ottocento, quasi per creare una patina
di antichità, mentre l'aspetto fonosimbolico è arricchito da rime interne
("Quale pupilla tremula sfavilla?") e da allitterazioni ("Venere che
versa / Un ricordo di fuoco... / Sull'incantato arco
della costa"). E la luce è altre volte protagonista, non solo quella
crepuscolare ma anche dell'aurora o del pieno mezzogiorno, incaricandosi di
ricacciare indietro l'ombra, di disperdere le tenebre della notte, penetrando
nei più intimi recessi dell'anima: "E la luce s'accende / dentro, nel profondo.
/ L'anima vibra, franano i silenzi, / chiusi recinti cedono".
Il verso
libero è prevalente ma sempre atteggiato classicamente e spesso nei momenti
culminanti raggiunge la misura canonica dell'endecasillabo, con l'effetto di
un'improvvisa accensione armonica e melodica; d'altra parte non mancano poesie
con uno schema metrico preciso, come appunto il componimento eponimo o il
Canto per una perdita organizzato in strofe di cinque settenari. Il dettato
è scandito nitidamente e si offre al lettore senza infingimenti, con cristallina
chiarezza.
Ma accennavamo
ad un legame segreto che unisce prima e seconda sezione: ebbene, nella raccolta
compare per ben cinque volte il raro aggettivo incipitario, che invano
cercheremmo nei dizionari, dove si può trovare soltanto come sostantivo, e per
giunta il legame è ribadito dal sostantivo reggente, per due volte fuoco
e per due volte soglia, mentre nell'occorrenza rimanente il sostantivo
aurora lo lega per àmbito semantico alla precedente, "Fuoco incipitario
incalza da Oriente", dove si allude appunto all'aurora. Questa sottolineatura
dell'inizio, sia quello della luce o della vita, ci sembra che chiuda
perfettamente il cerchio con il concetto di fine che l'aspirazione
all'eterno certo implica, in una vicenda perenne destinata a perpetuarsi nel
tempo attraverso la sua apparente contraddittorietà.
| |
 |
Recensione |
|