|
| |
Giovanni Chiellino,
in “Luce crepuscolare”, ci dà un saggio di alta ed
inconfondibile poesia: una silloge di 72 liriche,
distinte in 38, nella prima parte, e 34, nella seconda, che nascono dal nostro
faticoso ed affascinante andare, fatto di “suggestioni, ricordi, illuminazione,
lampi profetici”, come dice Eraldo Garello, nella
prefazione. Sentimenti gentili e affettuosi escono da
un linguaggio schietto e sicuro, vario per stile e registri espressivi.
Pierantonio Milone, nella postfazione, ne
precisa l’essenzialità lirica: “Una poesia che nasce tra distese di solitudine,
dettata dalla dolcezza e dal rimpianto”. Esperienze del vissuto lontano e
vicino ritornano nella memoria con l’insistenza del risveglio; ricercano nel
simbolo il bisbiglio che ridona il calore della
vita: “Sono l’eco della sillaba di Dio, | il flauto e la tromba del mattino,
| i
mille violini della brezza | che apre balconi sopra i colli” (p. 18).
Giovanni Chiellino, medicus
ac poeta, “chierico
grande”, direbbe Dante, “uomo dottissimo”, nella traduzione del De
Sanctis, rinviene, nel verso, il “pennello” del
Tintoretto, il “chiaroscuro” del
Caravaggio, nonché lo “sfumato” di Leonardo, ma,
in particolare, lo “scalpello” di Michelangelo. Spesso ci
troviamo di fronte ad un linguaggio che il sentimento scolpisce nell’immagine,
che lo spirito alla materia dona la forma, come si rinviene nel
miracolo della Bibbia: “Tunc
formavit Dominus Deus hominem
pulverem de humo
et inspiravit in
nares eius
spiraculum vitae, et
factus est homo in animam
viventem” ( Gen. 2, 7). La natura,
i luoghi del proprio vissuto, le persone care, presenti e lontane,
diventano i motivi ispiratori della poesia chielliana.
Bellissima l’espressione: “Hai il capo adagiato sulla luna, | se ti guardo
dal basso, | il viso nella schiuma delle ombre | sopra gli abissi della chiara
notte” (p. 17).
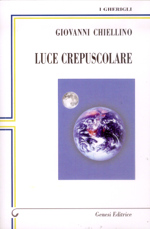 La figura femminile si colla
al centro dell’ispirazione: “Il vento che dal mare | sale verso riva e ti
scompiglia | i riccioli ribelli | lo raccogli su lastra di memoria | con gli
odori, le voci e i colori” (p. 21). Il bisogno di mitizzare la donna,
l’immagine della donna, la figura femminile, dà respiro al canto,
nell’estasi panica delle forme; allora, la poesia
diventa pittura, melodia di suoni, magia simbolica. Tanto si rinviene,
per esempio, nella memoria del passato, fra le pagine
inobliabili dell’
“Alcione” dannunziano, in particolare, nell’ “Undulna”,
dove musica e danza s’intrecciano, come nel “Bolero” di
Ravel: “I musici umani hanno modi | lor
varii, dal dorico al frigio: | divine
melodi |io creo nell’esiguo vestigio”; tanto,
riecheggia nel canto chielliano , là dove risponde
la “voce del mare”: “Scivola calmo il vento | sulla schiuma dell’onda e mi
sussurra | un parlare lontano che non canta | ma va oltre la soglia del pensare
| e che sognando ascolto.” (p. 48). Si coglie,
però, una differenza profonda, fra siffatta lirica
e quella dannunziana: in D’Annunzio prevalere l’ispirazione che nasce dai sensi,
e, quindi, si parla di magia iconica, fonica e simbolica; in
Chiellino, il “pathos” lirico è originato sempre
dall’urgenza dello spirito e allo spirito riconduce: tutto viene sublimato nel
riscatto del tempo; allora, la poesia diventa “nostalgia Dell’Eterno”.
Infatti, l’itinerario, in “Luce crepuscolare”, dai sensi porta allo spirito,
come dice Herman Holyborn:
“ Tento | il senso | che si fa sentimento | nell’immagine del pensiero” (“Salso
delle barene”, Genesi Editrice, Torino 2002, p. 69).
In altri termini, nel nostro poeta, la “poesia”
che “nasce sempre da una mente pacificata”, come dice Ovidio; una poesia, che
diventa “l’essenza del proprio essere”, nel miracolo della parola (Puskin).
Quindi, per il nostro poeta, la poesia è “l’eco della sillaba || il lieve
respiro del tuo sonno || il palmo che sospinge
l’onda || l’onda che distrugge il drago || il dito di Dio || la genesi del
verso” (p. 18). “Poesia, dice Ungaretti, è il
mondo l’umanità | la propria vita | fioriti dalla
parola”; poesia, per Chiellino, è “il labbro di
Dio” che ti rivela l’essenza del mistero, “triangolo” e “sfera” , gioia e
dolore, nel quotidiano passo dell’enigma, è l’urlo che ritorna nella memoria di
Auschwitz: “Fili spinati legano lo sguardo, |
solitudine su volti desolati.” (p. 24).
Il duello fra vita e morte si risolve sempre nel canto
dell’amore: “Omnia vincit
Amor: et
nos
cedamus Amori” (Virgilio, “Ecloga x, 69). Non
dissimile la “Sequenza” della liturgia pasquale: “Morse t vita duello
conflixere mirando:
dux vitae
mortuus,
regnat
vivus”. Nel poeta
Chiellino tanto si vive, nel nome della tradizione
cristiana, tanto in Cristo risorto: “Scimus
Christum surrexisse a
mortuis vere” (Ibidem). La fede trova sostanza
nell’atto vivificante di Dio che si manifesta nel
creato: “Germoglia il seme, si fa pianta e fiore |(…)| nel ciclo perenne del
sorgere e perire |(…)| dove l’Uno e il Tutto sono in eterno.”
(p. 27). La figura femminile si colla
al centro dell’ispirazione: “Il vento che dal mare | sale verso riva e ti
scompiglia | i riccioli ribelli | lo raccogli su lastra di memoria | con gli
odori, le voci e i colori” (p. 21). Il bisogno di mitizzare la donna,
l’immagine della donna, la figura femminile, dà respiro al canto,
nell’estasi panica delle forme; allora, la poesia
diventa pittura, melodia di suoni, magia simbolica. Tanto si rinviene,
per esempio, nella memoria del passato, fra le pagine
inobliabili dell’
“Alcione” dannunziano, in particolare, nell’ “Undulna”,
dove musica e danza s’intrecciano, come nel “Bolero” di
Ravel: “I musici umani hanno modi | lor
varii, dal dorico al frigio: | divine
melodi |io creo nell’esiguo vestigio”; tanto,
riecheggia nel canto chielliano , là dove risponde
la “voce del mare”: “Scivola calmo il vento | sulla schiuma dell’onda e mi
sussurra | un parlare lontano che non canta | ma va oltre la soglia del pensare
| e che sognando ascolto.” (p. 48). Si coglie,
però, una differenza profonda, fra siffatta lirica
e quella dannunziana: in D’Annunzio prevalere l’ispirazione che nasce dai sensi,
e, quindi, si parla di magia iconica, fonica e simbolica; in
Chiellino, il “pathos” lirico è originato sempre
dall’urgenza dello spirito e allo spirito riconduce: tutto viene sublimato nel
riscatto del tempo; allora, la poesia diventa “nostalgia Dell’Eterno”.
Infatti, l’itinerario, in “Luce crepuscolare”, dai sensi porta allo spirito,
come dice Herman Holyborn:
“ Tento | il senso | che si fa sentimento | nell’immagine del pensiero” (“Salso
delle barene”, Genesi Editrice, Torino 2002, p. 69).
In altri termini, nel nostro poeta, la “poesia”
che “nasce sempre da una mente pacificata”, come dice Ovidio; una poesia, che
diventa “l’essenza del proprio essere”, nel miracolo della parola (Puskin).
Quindi, per il nostro poeta, la poesia è “l’eco della sillaba || il lieve
respiro del tuo sonno || il palmo che sospinge
l’onda || l’onda che distrugge il drago || il dito di Dio || la genesi del
verso” (p. 18). “Poesia, dice Ungaretti, è il
mondo l’umanità | la propria vita | fioriti dalla
parola”; poesia, per Chiellino, è “il labbro di
Dio” che ti rivela l’essenza del mistero, “triangolo” e “sfera” , gioia e
dolore, nel quotidiano passo dell’enigma, è l’urlo che ritorna nella memoria di
Auschwitz: “Fili spinati legano lo sguardo, |
solitudine su volti desolati.” (p. 24).
Il duello fra vita e morte si risolve sempre nel canto
dell’amore: “Omnia vincit
Amor: et
nos
cedamus Amori” (Virgilio, “Ecloga x, 69). Non
dissimile la “Sequenza” della liturgia pasquale: “Morse t vita duello
conflixere mirando:
dux vitae
mortuus,
regnat
vivus”. Nel poeta
Chiellino tanto si vive, nel nome della tradizione
cristiana, tanto in Cristo risorto: “Scimus
Christum surrexisse a
mortuis vere” (Ibidem). La fede trova sostanza
nell’atto vivificante di Dio che si manifesta nel
creato: “Germoglia il seme, si fa pianta e fiore |(…)| nel ciclo perenne del
sorgere e perire |(…)| dove l’Uno e il Tutto sono in eterno.”
(p. 27).
Figura privilegiata del canto
chielliano è la donna,
interpretata in senso realistico, nella corposità evidente delle forme, ma anche
con tocchi di grazia, rapiti dal tempo, che ci ricordano il lamento
cavalcantiano: “Voi che per li occhi mi passaste ‘l
core | e destaste la mente che dormia” (G.
Cavalcanti, “Rime”, XIII, BUR, Milano 1987, p. 93).
In “Luce crepuscolare, “Tutto il cielo è nei tuoi
occhi, | il vento compone i Tuoi capelli, morbida polpa di squisito frutto |
sono le Tue labbra. || Dinanzi al Tempio della Tua Bellezza | il mio ginocchio è
sempre genuflesso.” (p.
32). In questa lirica, l’ispirazione e l’espressione,
più che agli stilnovisti, ci riportano al “Cantico dei Cantici”: “Tota
pulchra es, amica mea, |
et macula non est in te” (Cant.
4, 7).
L’interpretazione
si estrinseca, per ogni uomo, nel modello sublime della propria madre,
quale “mirabile prodigio” dell’alito divino: “Mai, non saprete mai, come
m’illumina | L’ombra che mi si pone a lato, timida, | Quando non spero più …”
(G. Ungaretti, “Giorno per giorno”,
‘Nessuno, mamma …’”). Accanto agli affetti familiari, l’amicizia ispira
momenti di particolare poesia, come nella lirica dedicata all’amico e poeta
Nevio Nigro: “ Non può tacere il mare, | non può
tacere se Talete | | pone nel suo
grembo | la culla della vita e della morte, se
purifica la mano di Caino | dal sangue del fratello, | se negli abissi del suo
corpo porta il vuoto e il pianto delle nostre angosce.”
(p. 43). In questa strofa, affiorano tutti i motivi
che ispirano la lirica chielliana: la parola, la
vita la natura e gli umani sentimenti, come la gioia
ed il pianto. La poesia, dice il Foscolo, “eterna
l’umano pensiero”, “vince di mille secoli il silenzio”, “Non può tacere se Nevio
Nigro, | poeta dei silenzi lunari, pone | sulle
labbra sinuose dei flutti | un melodico canto mentre le stelle | versano baci e
riflessi di luce | sul volto della sua donna distesa | sulle pause brevi del
cuore.” (p. 44). Bellissime le frecce semantiche
della parte finale, a testimonianza che l’ambiente
tutto si pone al servizio dell’ umana emozione; un
ambiente, quindi “antropomorfico”, per usare un’espressione felice del Russo.
La seconda parte della silloge,
“Pusilla”, viene
interpretata da Pierantonio Milone, come “diario intimo” dell’anima, come “un ‘Secretum’,
fatto di versi formalmente meno elaborati, ma forse più spontanei e toccanti”
(p. 113). Si tratta di “frammenti lirici, tasselli atti a
completare il mosaico dell’intera opera poetica”, dove,
come nel Petrarca, il poeta si interroga sul
travaglio oscuro della vita, sulla caducità delle cose che accompagnano il
nostro cammino. Pure, anche in “Pusilla”,
al centro dell’ispirazione c’è la donna, intorno alla quale si muove la giostra
del tempo e dello spazio, spira “il verbo della vita”: “Lo gridai al cielo
| e
alle distanze. | T’incantati. | Nacque da quell’incanto
| il nodo che ci unisce e che perdura.”
(p. 77). Una poesia quella di “Luce
crepuscolare”, che nasce dall’interiore dettato dell’anima e si dispiega nella
contemplazione del cosmo..
Vibrano le corde della memoria e della nostalgia sul “filo della vita”:
Non sapevo ancora che nel tuo sangue | di antica
genitrice | s’annodava l’universo. | Si generava il filo della vita.”
(p. 89).
Una silloge, in conclusione, di straordinaria
ricchezza di gusto e di cultura, di ispirazione
interiore e di espressione simbolica, accompagnata sulla tastiera dei sensi,
sublimati sempre da un gusto intenso e raffinato. In una realtà, nella
quale spesso la parola viene deformata per
ignoranza e per incapacità espressiva, “Luce crepuscolare” si presenta come
modello di imitazione e di proposta per la bella poesia, in particolare, e per
l’arte, in generale.
Torino, 18.04.2011, ore 09:05
| |
 |
Recensione |
|