|
| |
Albe e ne albe
Ci sono testi che per forza del dettato ed autenticità del
sentire e del coinvolgere si offrono, fin dalla radice, come restituzioni
preziose della terra in cui nascono, vivi e inquieti spiriti di una natura che
ciclicamente ripete se stessa tra cancellazioni di memoria e sgomenti di fede.
Entrando subito nel merito, a mio dire, sono lo sgomento e la fede infatti gli
assi portanti di questa seconda prova di Mario D’Arcangelo dopo l’esordio di
Senza tempe nel 2004. La terra – e la lingua che la racconta – sono quelle
dell’area teatino-frentana di Casalincontrada; le urgenze quelle di un mondo che
non riconoscendo più i suoi misteri rischia di interrompersi tra le asettiche – e
pericolose – neutralità del moderno. Si muove allora questa poesia, o per meglio
dire, si fissa, ricomincia sempre dove l’uomo nel suo recinto misura se stesso:
gli affetti familiari, la devozione agli avi e alla casa, la cura della terra
che viene dal lavoro e dall’amore in quel solco che fa, compie l’umano.
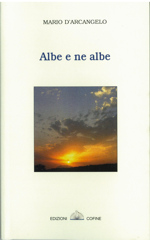 E’ una poesia di presenza pertanto quella di D’Arcangelo, a protezione o contro
gli sfaldamenti di una natura che più non corrisponde a chi ne va interrompendo
spirito e liturgie (l’uomo a sé sconosciuto in una civiltà dimentica delle
proprie geologie di ascrizione). Presenza che è data per genealogia con le forme
di una creazione che sopravvive e si manifesta nelle sue epifanie genitrici
anche per e nella parola, la consegna, di chi prima di noi ne ha incarnato
meraviglie e fatiche; gli avi, dicevamo, luogo essi stessi di un mondo da
apprendere nelle corde delle sue rispondenze, prossimità fedeli sospese tra
devozione e ritorni. Così se è vero, come avverte nella prefazione Fiorentino,
che qui il tempo è “un tempo di abbandono, di perdite, di smarrimento”, è
anche vero che il processo che questa crisi innesca può rivelarsi anche
come tempo
dell’opportunità alla luce dei suoi affidamenti e delle sue
ripartenze, mantenendolo aperto e radicato nel dialogo con una terra che non
smette mai di reclamare nel riconoscimento le proprie fondazioni. Perché
nell’assenza delle condivisioni, nel silenzio e nell’indifferenza delle case,
dove ” chi vo Criste / ognune se lo prehe”, l’alba vegliata da D’Arcangelo
rischia altrimenti di rivelarsi una non alba, una infinita e aggressiva
atemporalità di separazione che ci rigetta (e che la bellissima copertina nelle
striature del suo cielo non chiarisce). Motivo, questo, posto fin dal primo
brano a scansione del testo in quel riapprendimento che viene dall’azzeramento dello sguardo a cui il mistero per espansione e coinvolgimento si
riafferma, riconoscendosi e osservandosi l’uomo all’interno di un medesimo
destino di meraviglie e finitudini là dove anche la lingua ci incontra e fa
vivi: “ Na voja stasejàte de chenosce, / nu sense sbahuttùte de lu monne”. E’ una poesia di presenza pertanto quella di D’Arcangelo, a protezione o contro
gli sfaldamenti di una natura che più non corrisponde a chi ne va interrompendo
spirito e liturgie (l’uomo a sé sconosciuto in una civiltà dimentica delle
proprie geologie di ascrizione). Presenza che è data per genealogia con le forme
di una creazione che sopravvive e si manifesta nelle sue epifanie genitrici
anche per e nella parola, la consegna, di chi prima di noi ne ha incarnato
meraviglie e fatiche; gli avi, dicevamo, luogo essi stessi di un mondo da
apprendere nelle corde delle sue rispondenze, prossimità fedeli sospese tra
devozione e ritorni. Così se è vero, come avverte nella prefazione Fiorentino,
che qui il tempo è “un tempo di abbandono, di perdite, di smarrimento”, è
anche vero che il processo che questa crisi innesca può rivelarsi anche
come tempo
dell’opportunità alla luce dei suoi affidamenti e delle sue
ripartenze, mantenendolo aperto e radicato nel dialogo con una terra che non
smette mai di reclamare nel riconoscimento le proprie fondazioni. Perché
nell’assenza delle condivisioni, nel silenzio e nell’indifferenza delle case,
dove ” chi vo Criste / ognune se lo prehe”, l’alba vegliata da D’Arcangelo
rischia altrimenti di rivelarsi una non alba, una infinita e aggressiva
atemporalità di separazione che ci rigetta (e che la bellissima copertina nelle
striature del suo cielo non chiarisce). Motivo, questo, posto fin dal primo
brano a scansione del testo in quel riapprendimento che viene dall’azzeramento dello sguardo a cui il mistero per espansione e coinvolgimento si
riafferma, riconoscendosi e osservandosi l’uomo all’interno di un medesimo
destino di meraviglie e finitudini là dove anche la lingua ci incontra e fa
vivi: “ Na voja stasejàte de chenosce, / nu sense sbahuttùte de lu monne”.
L’attenzione, allora, è al rimando che ne conferma il legame nell’affidamento
domestico di se stessi, al punto di cerniera che ne rinsaldi o recuperi il
segno. Una poetica degli elementi, dunque, una verità di sapienza – fatta anche
di gesti e di riti – in cui antichità e prossimità convergono, incontrandosi o
scontrandosi in una coscienza del reale sì severa ma sempre orizzontalmente
rimessa ad una terra cui deve l’ascolto. Accostata con disponibilità umile, con
rispetto, la terra risponde – riconosciuto l’uomo nella sua duplice identità di
fanciullo e faber – si lascia ricomporre sprigionando ancora le sue preziosità e
i suoi miracoli. Qui, nella pietà che ci investe, nello strazio delle
separazioni, il poeta sembra stringere il centro di tutte le direzioni – di
spazio e di tempo, di incanti e di memoria – il percorso trovando compiendo nel
passo, nel sacco dove sui sentieri di orme grandiose raccoglie e preserva le
gemme di una storia che richiede pronuncia. E racconto, dentro al paesaggio
con Zanzotto ci verrebbe da dire , in cui le
montagne e gli uccelli si fondono, pazienti a raccontare, a raccogliere tutte le
lacrime (mute, quasi di pietra) insieme a tutti i sogni, e alle storie del
mondo. Ma, il racconto del mondo ha bisogno di fede, dalla fede e dal Racconto
nascendo. D’Arcangelo cristianamente lo sa, lo tiene a mente, soprattutto a
partire dalla seconda sezione, “Aspettanne l’aurore” dove più forte è la veglia
e la preghiera nel dialogo con la terra da cui nasce e a cui si rivolge, in un
assenso che se in buona parte dei testi è dato spesso dal confidamento
paziente – e mite – del cuore e da una speranza che cerca comunque di scuotersi
dall’immobilità della paura, nelle quattro poesie dedicate al terremoto
dell’Aquila si fa più urgente trovando il punto più alto di interrogazione
sull’orlo di un’anima atterrita, ferita, mutila.
Di fronte a una terra che da
fonte di vita s’è rivelata morte, nel buio più buio, nel delirio di lupi e di
uccelli maledetti, la parola si leva verso un cielo più alto a cui è rimesso
ogni appello nel conforto del pianto, ogni angoscia nei gesti da cui si riparte.
Restituzione dolorosissima della gente d’Abruzzo, sulla cui dignità, sulla cui
lotta non c’è rimando di “sone a stu lembe/ de ciele scerite,
de vuce e campane azzettite”. Eppure, proprio qui, in chiusura di testo
sembra spiegarsi l’eco dell’allodola che in “Rechiame” si scioglie nella
misericordia delle attese (“la terre arenasce a lu cante”). L’uomo non è
che partecipazione a quel coro, ci viene ricordato, incontro a ”la lume
ch’allume le cile e le sunne de glorie”; nel disegno che pienamente
ci svela e ci compie solo se per umiltà e in riconoscimento riposti. Questo
forse il bene vero di un libro di cui possibilmente si raccomanda, per meglio
disporsi alle sue scosse e ai suoi affetti ,una lettura a voce alta.
| |
 |
Recensione |
|